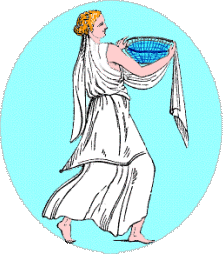 La
folla era enorme, compatta, ondeggiava come un mare
silenzioso dalla sommità dell’Arce capitolina, s’insinuava
nei fornici della Porta Trigemina, dilagando per la
spianata erbosa e umida del Foro Boario, fino alle sponde
del fiume. In quel punto il Tevere, superato l’ostacolo
dell’isola col sacello del dio Tiberino, placava il suo
ribollio di schiume. Non piú costretta, l’acqua
finalmente si spandeva per l’ampio greto creando l’unico
guado naturale tra la città e il territorio etrusco.
Proprio lí, dove brevi onde venivano a frangersi contro
la rena dell’argine, doveva svolgersi la “prova dell’acqua”
che avrebbe sancito, per iudicium Dei, la
colpevolezza o l’innocenza della vestale Tuccia, la sua
condanna o la sua salvezza. Morte e vita aleggiavano nell’aria
ventilata, si rincorrevano tra le colonne del Tempio di
Portuno, danzavano sui marmi dell’Ara Maxima dedicata a
Ercole. Quale delle due entità avrebbe prevalso, segnando
la sorte della sacerdotessa di Vesta accusata di
sacrilegio? La
folla era enorme, compatta, ondeggiava come un mare
silenzioso dalla sommità dell’Arce capitolina, s’insinuava
nei fornici della Porta Trigemina, dilagando per la
spianata erbosa e umida del Foro Boario, fino alle sponde
del fiume. In quel punto il Tevere, superato l’ostacolo
dell’isola col sacello del dio Tiberino, placava il suo
ribollio di schiume. Non piú costretta, l’acqua
finalmente si spandeva per l’ampio greto creando l’unico
guado naturale tra la città e il territorio etrusco.
Proprio lí, dove brevi onde venivano a frangersi contro
la rena dell’argine, doveva svolgersi la “prova dell’acqua”
che avrebbe sancito, per iudicium Dei, la
colpevolezza o l’innocenza della vestale Tuccia, la sua
condanna o la sua salvezza. Morte e vita aleggiavano nell’aria
ventilata, si rincorrevano tra le colonne del Tempio di
Portuno, danzavano sui marmi dell’Ara Maxima dedicata a
Ercole. Quale delle due entità avrebbe prevalso, segnando
la sorte della sacerdotessa di Vesta accusata di
sacrilegio?
- La
vergine si mosse dalla Casa delle Vestali, bianca e
leggera. Le infule sacre le cingevano il capo. Reggeva con
mano ferma il cesto che il Pontefice Massimo le aveva
porto. Si incamminò spedita per la via che dal Foro,
costeggiando il Palatino e tagliando il Velabro,
raggiungeva il fiume. Mille occhi erano puntati sulla
fragile sagoma candida che avanzava decisa, il vaglio tra
le mani. La videro affrontare con la stessa sicurezza la
correntía dorata che stremava le sue onde tra i ciottoli
e la sabbia. Tuccia fissò lo sguardo al cielo, invocò la
Dea perché le desse forza e tutela: un’ardente ma
scarna preghiera, che ebbe però il potere di scuotere le
anime degli spettatori e dei giudici. Un fremito percorse
la folla, mosse a benevolenza la Dea oggetto della divinatio.
Poi lo staccio venne immerso. Per attimi scomparve alla
vista, soltanto trattenuto dalle mani della sacerdotessa.
Quando riemerse grondante, Tuccia lo tenne alto davanti a
sé, cosí che tutti potessero vederlo colmo fino all’orlo.
Reggendolo sempre in quella positura, ripercorse la via e
lo riportò fino al Foro. Qui ne versò il contenuto
intatto ai piedi del Pontefice. La prova era superata, e
cosí, con l’aiuto di Vesta, Tuccia fu salva e assolta
da ogni sospetto.
 Di
quale colpa si era macchiata Tuccia? Probabilmente era
stata accusata di negligenza, per aver lasciato la
custodia del fuoco sacro, o peggio, per aver infranto il
voto di castità, che prevedeva la condanna a morte. Ma la
vergine non era colpevole di alcuna di queste due
trasgressioni: l’unica sua mancanza, agli occhi dei
detrattori, era forse il suo anelito alla purezza e alla
perfezione, reati gravissimi per chi non è capace di
simili slanci interiori. Per questo, le sacerdotesse di
Vesta dovevano spesso difendersi da malevole azioni
accusatorie e calunnie. In una altra occasione toccò alla
vergine Emilia discolparsi. Per la negligenza di una
novizia alla quale lo aveva affidato, il fuoco sacro si
era spento. Accusata e condannata, provò la sua innocenza
invocando la Dea e gettando sulle ceneri ormai fredde del
braciere un lembo che aveva strappato dalla sua veste di
lino. Dal brandello di stoffa si sprigionò una viva
fiamma con la quale il fuoco sacro si riaccese. Di
quale colpa si era macchiata Tuccia? Probabilmente era
stata accusata di negligenza, per aver lasciato la
custodia del fuoco sacro, o peggio, per aver infranto il
voto di castità, che prevedeva la condanna a morte. Ma la
vergine non era colpevole di alcuna di queste due
trasgressioni: l’unica sua mancanza, agli occhi dei
detrattori, era forse il suo anelito alla purezza e alla
perfezione, reati gravissimi per chi non è capace di
simili slanci interiori. Per questo, le sacerdotesse di
Vesta dovevano spesso difendersi da malevole azioni
accusatorie e calunnie. In una altra occasione toccò alla
vergine Emilia discolparsi. Per la negligenza di una
novizia alla quale lo aveva affidato, il fuoco sacro si
era spento. Accusata e condannata, provò la sua innocenza
invocando la Dea e gettando sulle ceneri ormai fredde del
braciere un lembo che aveva strappato dalla sua veste di
lino. Dal brandello di stoffa si sprigionò una viva
fiamma con la quale il fuoco sacro si riaccese.
- Gli
episodi, tra storia e leggenda, sulle gesta delle vestali
innocenti descrivono due tipi di ordalia, il giudizio di
Dio che gli antichi praticavano per stabilire la
colpevolezza o l’innocenza di soggetti incriminati per
sospetti indiziari e non in base a prove certe. Pur
variando nelle liturgie rituali e nei procedimenti
esecutivi, le ordalie, dal sassone Ordal o dal
germanico Urtheil, venivano praticate mediante l’uso
di elementi naturali direttamente o indirettamente
collegati all’acqua o al fuoco. Nel caso del fuoco,
camminare sui carboni ardenti, afferrare lame di metallo
incandescente, passare in mezzo a roghi o pire ardenti
senza bruciarsi. Nel Ramayana, l’eroina Sita, per
fugare le gelosie e i sospetti di Rama, affronta la prova
del fuoco e ne esce indenne e riscattata nell’onorabilità.
Nel caso dell’acqua, poteva trattarsi di acqua bollente
messa in un recipiente in cui il “prevenuto”, come
veniva chiamato l’accusato, doveva immergere la mano per
trarvi fuori un oggetto senza presentare segni evidenti di
scottatura. Trattandosi di acqua ghiacciata, il prevenuto
doveva esservi immerso e uscirne indenne, senza mostrare
segni di congelamento.
- L’acqua,
di un lago o di un fiume, veniva adoperata in epoca
medievale anche per i sospetti di stregoneria: l’accusato,
col pollice della mano destra legato all’alluce del
piede sinistro, veniva immerso nudo. Se affondava, come
normalmente doveva avvenire, era segno di innocenza, e
veniva quindi ripescato, se invece galleggiava, la sua
colpevolezza era provata.
- Accanto
alle ordalie per acqua e per fuoco, ve n’erano altre che
utilizzavano oggetti probanti, come la bilancia, che
rappresentava una variante della prova di galleggiamento
in acqua. Se il peso del sospettato si rivelava inferiore
a quello che aveva prima della recitazione delle formule
di scongiuro rituali, era colpevole. A volte, per fare da
contrappeso, si usava la Bibbia. Se il reo era piú
leggero del libro, la sua condanna era certa. Infatti,
secondo la tradizione esorcistica, la mancanza o la
riduzione di peso denunciavano l’appartenenza del
prevenuto a una setta satanica, o lo dichiaravano
praticante di stregonerie e malefíci.
- Spesso
l’acqua si prestava piú semplicemente alla preparazione
di infusi o decotti a base di aconito e di altre piante
velenose. Si otteneva la cosiddetta “acqua amara”. Era
innocente chi la ingeriva senza riportarne conseguenze
letali.
- In
altri casi, l’ordalia avveniva per inibizione psichica.
Quella per giuramento (purgatio canonica) si
applicava per lo piú nel caso di ecclesiastici accusati
di simonía o sacrilegio. Si chiedeva loro di recitare l’incipit
del Pater, del Gloria o del Vangelo di
Giovanni, dopo aver giurato. Se l’accusato non riusciva
a proseguire nell’enunciazione, la sua colpevolezza era
sicura. In altri casi gli si chiedeva di inghiottire l’ostia
consacrata. Il blocco della deglutizione costituiva un’altra
prova di reità. In questa linea, gli anglosassoni
praticavano l’ordalia detta corsnaed, derivante
da un procedimento similare usato dagli Egizi di
Alessandria. Dopo aver benedetto con apposite formule un
pezzo di pane misto a formaggio caprino, si chiedeva al
reo sospetto di ingoiarlo. Se gli riusciva impossibile
deglutire, veniva condannato.
- Come
spesso accade, quello che in tempi remoti derivava dalla
vera conoscenza, si degradava in forme di bassa
superstizione, pallidamente reminiscenti delle alte
scaturigini dei riti. A meno che, come nel caso del
sangue, tali contaminazioni venissero interdette dalla
potenza stessa dell’elemento. Vale qui ricordare la
peculiarità del sangue: un misto di acqua e fuoco,
liquido di coltura dell’Io, identità a sé stante,
sospesa in una dimensione tra l’uomo e la divinità.
Quasi una sorta di interfaccia che rende possibile scambi
ed empatie tra immanenza e trascendenza, fisicità e
soprannaturale, materia e spirito.
- Famoso
è il giudizio del sangue di cui ci parlano due testi
della tradizione letteraria anglo-germanica. Nella Canzone
dei Nibelunghi viene riportato il fenomeno prodigioso
che riguarda il cadavere di Sigfrido. All’avvicinarsi
del traditore Hagen, autore dell’assassinio dell’eroe
della saga, le ferite emettono sangue vivo, come volessero
gridare un’accusa dolente e terribile.
- Lo
stesso evento viene descritto da Shakespeare nel secondo
Atto del Riccardo III, quando il protagonista si
trova davanti alla salma di Enrico VI da lui trucidato:
|
Lady
Anna: |
«Oh, miei
signori, guardate, guardate!
Le ferite del morto re Enrico
riaprono le bocche coagulate
e come fresche sanguinano…
E tu, deforme sconcezza, arrossisci,
poiché è a causa della tua presenza
che nuovamente questo sangue sgorga!» |
|
- Acqua
e fuoco costituivano quindi gli elementi base della
maggior parte delle antiche ordalie. In essi sono latenti
forze sorgive e cosmiche, capaci di veicolare con
efficacia e chiarezza i messaggi evocativi dall’uomo
alla divinità o, come presso le popolazioni melanesiane e
polinesiane, sollecitare l’intervento del mana,
lo spirito immanente nella natura e nei suoi oggetti e
fenomeni.
- Fede o
magia che fosse, l’ispirazione a monte dell’atto
divinatorio scaturiva da un forte convincimento dell’esistenza
del divino, del metafisico, o semplicemente del
sovrannaturale, cui si demandava l’autorità piena del
giudizio. Proprio perché esulanti dal limite delle leggi
fisiche, tali forze agivano da segnali del mondo
ultraterreno quali testimonianza ineccepibile della
verità o della menzogna. Benché, al pari di tutte le
azioni umane, si prestasse ad arbitri e forzature, l’ordalia,
nelle sue varie forme, ha rappresentato quindi la
necessità dell’uomo di avere una “giustizia vera”,
affidabile, equa. Delegandone la potestà al Mondo
spirituale, agli spiriti, alle forze occulte della natura,
ai mana o alla semplice suggestione per arcani e
misteri, egli ha cercato di garantirne la qualità e l’imparzialità,
oltre a conferirle il crisma del sacro perché s’imponesse
al rispetto delle comunità umane prescindendo dalle
condizioni politiche e culturali vigenti in un particolare
momento della loro storia.
- Lo
stesso Dante, nel De Monarchia, riconosce la
validità dell’ordalia quale strumento per invocare il
giudizio di Dio: «…ogniqualvolta il giudizio umano
viene meno, o perché le tenebre dell’ignoranza
nascondono la verità o perché manca un giudice
autorevole, si deve ricorrere, se non si vuole che la
giustizia resti negletta, a Colui che tanto l’amò da
rispondere col proprio sangue alle sue esigenze» (Libro
II, IX-1).
- Fu con
l’avvento dell’Illuminismo e con Montesquieu in
particolare (Lo spirito delle leggi), che l’opzione
trascendente della giustizia venne relegata tra le
anticaglie delle umane credulità. Il positivismo logico
poneva le basi delle scienze sociali ed economiche
moderne, stabilendo che soltanto la Dea Ragione dovesse
occuparsi degli ordinamenti giudiziari, oltre ad impartire
le direttive per le scelte morali e civili dei popoli. L’indirizzo
razionalistico sembrò allora quello giusto, e cosí
giudici e avvocati hanno sostituito maestri e ierofanti.
- Ma
ciò non ha costruito quel paradiso che il materialismo
agnostico prometteva, sottraendo l’umanità alle fumerie
d’oppio delle religioni e del sovrannaturale. E la
giustizia non è migliorata. Molti popoli tuttora
applicano la legge del taglione, eseguono condanne
capitali, sottopongono i rei, o ritenuti tali, a
detenzioni oltraggiose della dignità umana. E non è
detto che tali deterrenti servano a scoraggiare il
crimine, il quale non solo non è diminuito, ma si è
connotato di un cinismo e di un’abiezione sconosciuti ai
rei delle antiche ordalie.
- L’uomo
della terra, avendo abbandonato Dio, è solo, perduto in
un territorio senza riferimenti affidabili, pur se con
infiniti e sempre nuovi miraggi. Era previsto che ciò
avvenisse. Egli doveva stabilire un nuovo rapporto con la
Divinità, perché la ricercasse non nelle forme
esteriori, bensí in se stesso. Doveva capire che il
mirabile oggetto di sublimazione non è nel feticcio, ma
nel segreto tabernacolo dell’Io. Comprendere infine che
non sono le leggi contenute nei codici, che servono solo a
punire o a coartare, a poter realizzare l’essere morale.
L’uomo eticamente e spiritualmente compiuto avrà come
polo di riferimento la propria interiorità, unica forza
da chiamare in causa a testimonianza e tutela del vero e
del giusto. Essendo in lui da sempre, trascurata ma viva,
l’alta legge del cuore.
Leonida I. Elliot |
|