|

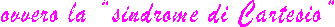
 Tra
le ipotesi piú verosimili formulate dagli storici circa
la derivazione etimologica del mese di giugno, c’è
quella collegata alla figura di Giunio Bruto. Secondo la
tradizione, fu lui a cacciare da Roma Tarquinio il
Superbo, alle Calende di giugno dell’anno 509 a.C.,
diventando Primo Console e istituendo la Repubblica. Per
onorarlo, i Romani diedero il suo nome al mese. Tra
le ipotesi piú verosimili formulate dagli storici circa
la derivazione etimologica del mese di giugno, c’è
quella collegata alla figura di Giunio Bruto. Secondo la
tradizione, fu lui a cacciare da Roma Tarquinio il
Superbo, alle Calende di giugno dell’anno 509 a.C.,
diventando Primo Console e istituendo la Repubblica. Per
onorarlo, i Romani diedero il suo nome al mese.
Ma
una leggenda vuole che il re etrusco non lasciasse l’Urbe
senza reagire. Ordinò che tutto il grano da poco
mietuto nell’Agro regio, tra i colli Quirinale e
Pincio e gli argini del fiume, venisse gettato nel
Tevere. Tanto era il frumento raccolto che il fiume ne
divenne ingombro, formando al centro del suo corso l’Isola
Tiberina.
Dopo
la cacciata dei Tarquini, l’Agro reale divenne
pubblico e votato ad area sacra prendendo il nome di
Campo Marzio. Vi furono edificati vari templi: quello
ipogeo a Dite e Proserpina (Tarentum), e quelli a
Marte, a Giunone e a Iside.
Il
mese di giugno è legato anche alla figura di Giovanni
Battista. Egli rappresenta il Sole declinante del
solstizio estivo, quando l’astro abbandona l’apogeo
dello Zodiaco celeste e inizia la sua fase calante che
avrà termine col solstizio d’inverno: a quel punto il
Sol Invictus inizierà la sua ascesa sulla linea
dell’orizzonte astrale. «Io devo scendere e lui deve
salire» cosí il Battista disse ai discepoli che gli
chiedevano perché dovessero abbandonarlo per seguire l’Uomo
che li avrebbe battezzati con lo Spirito Santo e col
fuoco e non piú con l’acqua.
La
parabola discendente del Battista si esaurì sotto il
colpo di spada che gli recise la testa per ordine di
Erode Antipa, irretito dagli intrighi di Erodiade e
dalle grazie lussuriose di Salomè. Ora quella testa è
venerata nella chiesa di San Silvestro a Roma, detta
appunto “in Capite” perché conserva la sublime
reliquia portata a Roma nel 1135 e destinata a quella
chiesa da papa Innocenzo II.
Per
strana coincidenza, ma poi non tanto per chi è aperto
alle combinazioni trascendenti, San Silvestro in Capite
segna anche il punto dove sorgeva l’ingresso del
tempio dedicato al Sol Invictus, fatto costruire
dall’imperatore Lucio Domizio Aureliano nel 274 d.C.,
che da Palmira, in Siria, aveva fatto portare a Roma la
statua di Helios Belos, divinità venerata in quella
città.
Chi
fa shopping nelle strade che ospitano le boutique piú
esclusive e trendy del mondo, forse ignora di
calpestare quella che fu una delle aree sacre per
eccellenza dell’Urbe. Il naos, la cella del
Tempio Solare, dovrebbe trovarsi piú o meno all’incrocio
tra le vie Borgognona, Bocca di Leone e Condotti. E
deviando per San Lorenzo in Lucina, si giunge esattamente
sul luogo dove Augusto fece erigere l’Ara Pacis,
promettendo ai sudditi, che l’avevano investito del
potere assoluto, pace e prosperità. Nel 1938 il
monumento, che era inglobato quasi per intero nelle
fondamenta del Palazzo Fiano-Perelli-Almagià, fu
recuperato con una sofisticata operazione d’ingegneria
archeologica e ricostruito nell’attuale ubicazione sul
Lungotevere.
L’Ara
Pacis fu, in ordine di tempo, l’ultimo dei monumenti
inaugurati da Augusto. Votato dal Senato nel 13 a.C.,
venne dedicato con una solenne cerimonia officiata dallo
stesso Imperatore nel 9 a.C. Sorgeva accanto all’Horologium,
la grande meridiana che Augusto aveva inaugurato l’anno
prima adoperando come gnomone l’obelisco fatto venire
da Heliopolis, in Egitto, ora in Piazza di Montecitorio.
La sagoma del monolito proiettava l’ombra che tangeva
esattamente il centro dell’Ara nel giorno del
genetliaco dell’Imperatore.
Nei
fregi e rilievi in marmo di Carrara scolpiti all’interno
e all’esterno del recinto che chiude l’Ara, Augusto
viene raffigurato al centro di una processione rituale.
Con lui sono effigiati i membri della famiglia
imperiale, secondo un ordine di priorità dinastica, e
personaggi importanti del governo e della corte.
L’Ara
Pacis non è soltanto un monumento celebrativo della
gens Iulia e dell’oligarchia dominante a Roma.
Trascendendo le intenzioni dello stesso Augusto, essa
incarna il simbolo del potere umano che, avendo tutto
conquistato e realizzato nell’ambito materiale, si
volge al sacro. E meno che mai vuole essere un messaggio
teocratico o ierocratico. Intende piuttosto stabilire
agli occhi della storia la sintesi dei poteri politico e
religioso nella figura del sovrano, operante nel
rispetto delle leggi naturali, umane e divine. Nella
descrizione realistica del paesaggio, nel naturalismo
con il quale vengono resi i particolari di animali,
piante e infiorescenze, attraverso l’illustrazione
solenne e al tempo stesso condiscendente dei personaggi
dediti alla celebrazione liturgica, cogliamo in forma
palese, quasi calligrafica, l’allegoria dei tre
ordini, naturale, umano e divino, ai quali dovrebbe
rispetto chiunque si impegni nell’esercizio di ogni
attività, da quella politica all’economica, alla
creativa.
Augusto
ne era consapevole. Nella temperie neopitagorica dell’epoca,
vibravano aneliti di giustizia, di moralità pubblica e
privata, e soprattutto di riacquisto di un nuovo
rapporto tra l’uomo – realizzato socialmente,
intellettualmente ed eticamente – e la divinità. Una
divinità anch’essa rinnovata nella sua essenza
suprema e nelle manifestazioni immanenti, secondo le
aspettative messianiche ed escatologiche che quegli anni
nutrivano: l’alba del Grande Anno, segnata dal ritorno
della costellazione della Vergine nella sua posizione
originaria nell’ètere celeste, e l’avvento del Puer,
il divino fanciullo che avrebbe riscattato l’umanità.
Forse non è del tutto inventata la leggenda che vuole
Augusto testimone di un evento prodigioso: l’apparizione
sull’arce capitolina di una donna splendente che,
librata su un altare votivo, reggeva tra le braccia un
fanciullo, mentre una voce arcana diceva: «Haec ara filii Dei
est». Su quel sito Augusto, turbato da quella
visione, fece erigere un tempio, diventato poi l’Ara Cœli.
Ottaviano
rappresentava l’apogeo solare della romanità. Dopo di
lui i fasti dell’Urbe e dei suoi valori si avviarono
al declino, come l’astro solstiziale del Battista. Ma
iniziava con la nascita di un fanciullo solare, in uno
sperduto villaggio di una provincia dell’Impero, la
parabola ascendente del Logos imperituro, il Cristo, che
doveva rivelare agli uomini di essere Dei in potenza,
destinati a realizzare il Regno dei Cieli sulla terra
redenta. Quella Saturnia Tellus scolpita in
uno dei fregi dell’Ara Pacis, che, proprio per la sua
complessa simbologia esoterica, travalica la contingenza
storica e culturale che la produsse, per assurgere a
voto sacrale di tutta l’umanità, nella sua essenza
universale.
Per
questo forse le si accaniscono contro ambigui progetti
di restauro e trasformazione, che, a ben giudicare,
sembrano piuttosto l’ennesimo tentativo di damnatio
memoriæ perpetrato non per obliterazione ma per
deturpazione e stravolgimento dei singoli valori che l’Ara
intende consegnare agli uomini di tutte le etnie e
religioni del mondo.
Accanto
alla famigerata “sindrome di Stendhal”, che colpisce
chi esagera con la visione di opere d’arte e siti
archeologici, da secoli subdolamente serpeggia, tra le
pieghe della storia, quella che potremmo definire “sindrome
di Cartesio”, in cui il razionalismo scientista tenta
di dannare nell’inferno dell’oblio storico e
culturale i segni e i reperti che palesemente inneggiano
al divino, al sacro e al trascendente, e che sono
presenti nelle vicende e nelle opere umane. Ma sono,
queste, strategie destinate a fallire. Il seme del sacro
veleggia nell’anemocoro del grande soffio universale,
e feconda il cuore degli uomini giorno per giorno,
stagione dopo stagione, contro ogni avversità e
inganno.
Finché
la materia non sarà Spirito, e l’uomo Angelo.
Ovidio Tufelli
|