- Luglio volgeva al termine. Da
due giorni il segno del Leone governava il cielo. Seduto
nella quiete del giardino fiorito, il poeta guardava il
vasto scenario urbano ai suoi piedi. La collina di
Highgate, pur nella sua brevità morfologica, dominava la
città, anzi la solcava: una grande prora verde davanti
alla quale i tetti rugginosi di Londra si aprivano come
tanti relitti di un continente frantumato da immani
cataclismi. Il sole calante di quella giornata di piena
estate accendeva riverberi da quei frammenti, suscitava
lampi e rossori nelle ardesie, nei cotti delle cortine.
- Nuvole pigre scorrevano in
cielo, animando inesauribili figurazioni. Pensò a Goethe.
Poco prima della morte, avvenuta da due anni, il grande
romantico tedesco era stato autore di un trattatello sulla
forma delle nuvole. Per amore di una fanciulla
diciannovenne, Ulrike, cosí avevano riferito le cronache.
Ma lui non credeva che l’olimpica intelligenza di Goethe
avesse potuto indulgere in scivolamenti passionali. Si era
trattato piuttosto, a suo avviso, dell’ennesima sortita
di un genio eclettico, animato da un sapere felice e
appagato, teso a riconfermare la presenza di Dio nelle
molteplici realtà del mondo creato. Un rapporto col
divino, quello dell’Autore del Faust, intrattenuto con
continua vigilanza razionale, per evitare i facili
abbandoni estatici, le identificazioni passive e non
meditate. Goethe aveva trovato il trascendente percorrendo
l’arduo cammino della ricerca come un cavaliere del
Graal, audace e sicuro; piú che il pagano Sigfrido, egli
incarnava Parsifal, armato di coraggio e di fede.
- La mente del poeta si spostò
sul panorama letterario inglese. Molti uomini di scienza e
cultura, come il suo amico De Quincey, cercavano anch’essi
il superamento del materico nei fumi dell’oppio o nell’ebbrezza
dell’alcool. Ma da quei percorsi ritornavano svuotati e
piú dubbiosi e tormentati di prima. Cosí era stato anche
per lui, molti anni addietro, finché il suo viaggio non
lo aveva fatto approdare alla dimora di Gilman, su quella
collina ai margini della grande città.

- Qui venivano a lui da ogni dove
uomini e donne di varia età e condizione, per chiedergli
se e come nelle sue peregrinazioni avesse incontrato la
divinità. Questa era la domanda che campeggiava su tutte
nella vasta sala degli incontri. Ad essa immancabilmente
seguiva la richiesta che dalla viva voce dell’Autore
venisse narrata la genesi ispirativa del grande poema che
avrebbe tramandato il suo nome alla storia. Perché erano
certi, molti degli uditori, che in quella ballata
marinaresca, umorata di salsedine e schiume oceaniche, che
narrava di un vascello irretito dai ghiacci eterni del
polo o insidiato dai sargassi, incalzato da onde immani,
visitato da ibride e sovrumane creature, il poeta avesse
scorto baluginare la scintilla del divino per illuminare
il suo genio creativo.
- Allora l’idealismo
trascendente tanto caro al suo maestro Cudworth e a
Shelling accendeva le sue parole di una luce metafisica,
mutandosi in fuoco di affabulazione misterica. E mentre l’instancabile
Carlyle infittiva il suo taccuino di appunti per la futura
biografia dell’oratore, lui, il poeta, conduceva tutti i
presenti, ormai catturati dal potere immaginifico dell’evocazione
verbale, in una fumosa taverna di Watchett, sul canale di
Bristol.
- Era l’autunno del 1797, e la
sera incipiente sollevava dalle scure acque, metà marea,
metà corrente dei fiumi Severn e Avon, fantasmi di nebbie
che i fanali dei battelli trafiggevano a tratti. Nel
locale, marinai, tessitori, mercanti e persino negrieri,
contrabbandieri e transfughi da paesi lontani. Tutti
bevevano birra e rhum, tutti avevano storie prodigiose o
terribili da raccontare. Al tavolo dove sedeva il poeta
insieme a Wordsworth e alla sorella di questi, Dorothy, li
raggiunse un certo Cruikshank, loro vicino di casa.
Normalmente riservato e avaro di confidenze, ora l’uomo,
disinibito forse per effetto dell’alcool, volle
raccontare una storia che conteneva il segreto della sua
passata esistenza.
- «Siete gente di lettere –
disse – e ne potreste ricavare lo spunto per un racconto».
- Cruikshank era stato secondo
ufficiale sui mercantili in partenza da Bristol per le
Indie. Thè, cotone, spezie, tessuti, tabacco, ceramiche e
porcellane, questi i carichi usuali in una ininterrotta
spola tra l’Europa e l’Oriente, sulle rotte ormai
battute da centinaia di vascelli. Quasi una routine. Poi
capitò l’episodio che doveva mutare la sua vita.
Durante un viaggio di ritorno, la nave aveva dovuto
raccogliere da un porto di Ceylon una ciurma di
fiocinatori sopravvissuti al naufragio della loro
baleniera, che incrociava nell’Oceano Indiano. Con quei
marinai salirono a bordo violenza e brutalità. Uccidere,
piú che una necessità di sopravvivenza o una fonte di
reddito, era diventata una sadica manía, una libidine che
ormai piú nulla riusciva a saziare.
- Un avvenimento inusuale doveva
mettere in luce questa loro degenerata indole assassina.
Avevano da poco doppiato il Capo di Buona Speranza quando
un branco di albatros, stanchi e affamati, venne a posarsi
sulla nave. Senza motivo e con inaudita ferocia i
fiocinatori, seguíti da tutta la ciurma, e nonostante il
tentativo di opposizione di Cruikshank, si accanirono
contro i miti e fiduciosi volatili, facendone strage. Egli
giunse ad affrontare fisicamente gli scalmanati, ma venne
tramortito e gettato nella stiva. La segregazione gli
risparmiò la vista del comandante gettato fuoribordo e
dell’atto sacrilego col quale l’equipaggio, preda
della frenesia scatenata dai fiocinatori, concluse la
terribile mattanza: uno degli uccelli piú maestosi del
branco, crocefisso all’albero di maestra, era stato poi
trafitto dalle picche e dalle lance dei carnefici.
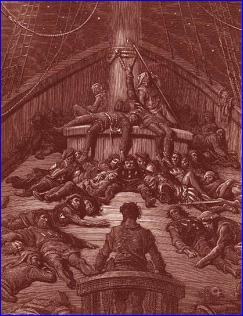
- Quell’inutile eccidio contro
le creature amiche dei marinai aprí il varco alla
maledizione e alla follia. Sangue chiamava sangue.
Scoppiarono risse a bordo, che da semplici scaramucce
rapidamente si trasformarono in una vera e propria
battaglia. Al termine dei violenti scontri, morti e feriti
ingombravano ponti e boccaporti. Nella disperazione
Cruikshank riuscí a forzare la botola della stiva e a
ritornare sul ponte. Qui, dopo aver vinto l’orrore di
quanto si presentava ai suoi occhi, tentò di riprendere
il governo della nave e di soccorrere i feriti, ma
inutilmente. In breve tempo si trovò unico superstite in
uno scenario di morte e con l’imbarcazione ormai presa
nella scia di forti correnti. Da solo non poteva
contrastare le forze della natura e quelle piú occulte
che sembravano essersi accanite contro i suoi sacrileghi
compagni e contro il naviglio che ne trasportava adesso i
corpi senza vita. Un’angoscia mortale gli penetrò nel
sangue come un deliquio. Si abbandonò al destino, mentre
la nave col suo macabro carico navigava verso l’ignoto.
- Quanto durò il viaggio non
riuscí a registrare. Un solo ricordo: quando, in un
momento di lucidità, si prostrò in ginocchio presso la
barra, invocando Cristo e gli angeli del cielo. E questi
giunsero, leggeri, bianchi, luminosi e silenti, aliando
sui corpi freddi e rigidi, ne raccolsero le anime. Gli
sfiorarono la fronte restituendogli l’energia necessaria
ad impugnare la ruota del timone e riprendere il governo
del vascello. Vele, corde, sartíe, obbedivano a
invisibili mani, veloce la chiglia solcava le onde, la
polena danzava tra le spume. Vennero incontro al veliero
le prime isole, le spiagge dorate del tropico, la
salvezza.
- Al termine del suo portentoso
racconto, Cruikshank si fece promettere dai tre che mai
dalle loro bocche sarebbe uscita parola sul protagonista
di quell’avventura. E ciò perché, come bene questi
sapevano, i sopravvissuti ai naufragi e ai disastri
marittimi erano valutati alla stregua dei ciechi, dei
suonatori ambulanti, dei disertori e dei riscattati dalle
mani dei Turchi. Raccomandazione superflua. Wordsworth e
Dorothy non credettero a quella storia. Soltanto Charles
Lamb, al quale il poeta la raccontò in seguito, la trovò
affascinante.
- «Fanne tu un poema, Coleridge,
che possa dare speranza all’uomo, perduto nell’oceano
dei suoi peccati. Una testimonianza poetica del Fato che
inesorabilmente colpisce chi infrange la legge naturale, e
della misericordia divina che soccorre chi a lei si
affida. E anche per manifestare agli uomini che esistono
quelle tante cose che, come Amleto dice a Orazio, “sono
tra cielo e terra e che i nostri sistemi filosofici mai
riusciranno a concepire”».
- Si chiedeva spesso se il suo
poema, quella Ballata del vecchio marinaio, intrisa di
salsedine e mistero, avesse raggiunto lo scopo che il suo
amico Lamb gli aveva indicato. Perché, quando terminava
il suo racconto nella grande sala degli incontri, molti
tacevano presi dall’emozione, altri invece ponevano
domande insidiose se non improntate allo scetticismo. Ma
egli, il poeta, sapeva che cosí doveva essere, perché
cosí era stato dall’inizio del mondo, con una parte
dell’umanità che lavorava per dimostrare l’esistenza
del soprannaturale, l’altra per negarla. Al cospetto del
creato, la filosofia si chiedeva il perché delle cose, la
poesia le esaltava, ritenendole emanazione del divino.
- Il sole era ormai prossimo al
tramonto, ma un diffuso chiarore dorato permetteva ancora
di scorgere i contorni del paesaggio, di notare le forme
umane che lo animavano. In una casa a mezza costa, poco
distante dal suo punto di osservazione, davano una festa.
Si udivano lievi i rumori della convivialità: il vociare
allegro, le risa discrete, i suoni di strumenti.
Affluivano gli invitati, molti di essi giovani, vestiti
con abiti variopinti e fantasiosi. Fu forse un gioco della
fantasia a riproporgli la scena di inizio della sua
Ballata: gli sembrò di vedere un vecchio, dimesso nel
vestire ma eretto in una composta solennità, fermare uno
di quei convitati e parlargli, per renderlo partecipe di
chissà quale prodigioso segreto. Qualunque fosse la
storia che quel vecchio, a mezzo tra il pellegrino e l’eremita,
volesse raccontare al giovane, di certo questi non sarebbe
stato piú lo stesso al termine della narrazione. Il suo
mondo tranquillo, votato a una razionale, simmetrica
realtà, alla rassicurante quotidianità, si sarebbe
aperto su un universo governato da leggi stabilite da una
piú alta Ragione, dalla pura Immaginazione, ed egli
avrebbe da quel momento navigato in un oceano di essenze
ineffabili, un mare sconosciuto ma esaltante, visitando
regioni ignote dalle quali non gli sarebbe stato piú
possibile ritornare se non radicalmente trasformato nel
cuore e nella mente. Avrebbe riportato da quel viaggio la
conoscenza che vi sono piú esseri invisibili che visibili
nell’universo, sul quale la divinità veglia, cosí come
veglia sull’uomo in ogni istante. Basta ben pregare e
amare in egual misura gli esseri umani, gli animali e le
cose, siano essi belli o brutti, grandi o piccoli, miseri
o risplendenti. «Perché quel Dio d’amore che ci
assiste fece ogni cosa e l’ama».
- La luce stava ormai cedendo all’oscurità
e il caldo giorno di luglio languiva verso la fine. A un
tratto il poeta vide le candide nuvole randagie nel cielo
crepuscolare assumere forme diafane, stringersi in schiere
palpitanti d’ali e di bagliori iridescenti. Poi i
bianchi sciami angelici si diressero con un volo
frusciante verso la collina di Highgate. Era pronto. Da
anni li attendeva.