 Dinanzi a lui, ove egli veramente le contempli, le forme della bellezza e della vastità sono l’impronta del pensiero celeste, che è il pensiero originario perduto.
Dinanzi a lui, ove egli veramente le contempli, le forme della bellezza e della vastità sono l’impronta del pensiero celeste, che è il pensiero originario perduto.
L’uomo può ritrovare il pensiero perduto, ove colga in sé la luce che muore per essere suo pensare, per essere suo percepire. È giunto il momento che egli la riaccenda in sé: tutta la sua storia avendolo condotto a tale momento.
Non ha altro senso la sua vicenda.
Massimo Scaligero, Dell’Amore Immortale

“L’Idiota” nell’interpretazione di Giorgio Albertazzi
«La bellezza salverà il mondo»: almeno cosí, ne L’Idiota, Feodor Dostoevskji fa dire al principe Myskin. Divenne in seguito una frase cardine della storia letteraria, e ancor oggi è citata in scritti e discorsi di varie personalità, alcune piuttosto autorevoli, altre esenti da ogni riferimento ai caratteri dell’autorevolezza ma non per questo meno efficaci.
Sono sempre rimasto un po’ spiazzato dalla citazione del grande scrittore russo. Eppure è un bel pensiero, coraggioso, edificante. Un autentico sprone al miglioramento di sé; e – cosa di maggior dinamismo e portata – sostiene pure un finalismo cosí ammirevole e centrato che persino un’anima schiva, poco incline alle adesioni corali, come, per esempio, la mia, non può ignorare senza sentirsene in qualche modo colpevole.
Tale premessa mi offre l’opportunità di rifletterci sopra; voglio dire, mettere l’aforisma sul bancone di lavoro, come un fenomeno da studiare con scrupolosa osservanza, per cercare di capire il mo-
tivo in base al quale l’elevatezza del proposito di Myskin, non fa sorgere nella mia interiorità una reazione convincente. O almeno, non tanto convincente quanto sembrerebbe doverlo essere, data l’enfasi che normalmente accompagna, diffonde, e qualche volta circoscrive, l’inciso.
Non mi lascio incantare dalle belle parole neppure quando compongono una frase proverbiale. A costo di passare per il “Grillo” di turno, posso sminuzzare la sintesi dialettica (usando anche la calma e l’imperturbabilità che ai passionari della vita politica manca quasi sempre), ponendo degli interrogativi che, senza ombra di sarcasmo, credo giustificati in questi casi: “Di quale bellezza vogliamo parlare?”; “Cosa s’intende per mondo? Il pianeta? L’umanità? Tutti e due?”; “Il verbo salvare è adoperato in senso materiale o ideologico culturale?”.
È cosí che, dopo aver smontato il costrutto, la grandezza del messaggio rimpicciolisce e si finisce con il solito scetticismo: “Non è chiaro. Può voler dire tutto e niente ad un tempo”.
Sarebbe cosa utile, ai fini della presente disamina, cominciare da coloro che hanno in vari modi sostenuto il valore di un’affermazione del genere: Sant’Agostino, Nieztche, Papa Francesco; oppure ricorrere a consultare il saggio del bravo Cvetan Todorov, che racconta attraverso le storie degli “Avventurieri dell’Assoluto” (Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke e Marina Cvetaeva) tre modi drammaticamente umani di concepire un estetismo esistenziale traendolo direttamente dall’esistere stesso.
Ma si finirebbe per far torto a tutti gli altri pensatori (anch’essi Avventurieri dell’Assoluto, o talvolta del Relativo) che con la loro vita si sono assunti l’impegno, altrettanto egregio, di compiere l’impresa, magari in modo personale, evitando di seguire contorcimenti intellettuali, ostentazioni sussiegose e banalismi visionari che poi, nel volgersi di una dialettica esplicativa, inevitabilmente sfumano e scompaiono senza lasciar traccia di sé.
Pertanto, come da un po’ mi succede, ho voluto isolare, per cosí dire, alcuni momenti letterari e non, i quali mi hanno fornito gli ingredienti per metter assieme questo scritto. Sarà un manicaretto o un pasticcio? Non sono io quello chiamato a dirlo; il mio modo di cucinare dipende dal gusto personale e dall’estro del cimento. Dopo di che, altro non resta che la fiducia nel prossimo.

Agnolo Bronzino «Lorenzo de’ Medici»
Confesso che nei dopocena tendo a rilassarmi guardando la televisione; non ho ancora capito bene se si tratta di un caso in cui la coscienza si ritaglia un riposino assolutamente defadigatorio e va a cercarselo tra la copiosa spazzatura offerta dalle tele-emittenti, o se invece l’autoconcessione all’abbassamento di livello, faccia da preludio a un rinnovato impegno verso qualche luminosa ricerca.
Tenendomi basso, propendo per la prima probabilità. Del resto, pure Pirandello concluse una celebre novella con la frase: «…poiché, fra le sue tante cose, l’uomo è anche un èbete».
Digressione a parte, triste, grottesca e non risolutrice, ho seguito le vicende del telefilm sui Medici (3a Stagione, cosí si dice) e sono rimasto colpito, intendo seriamente colpito, dal finale, quando Lorenzo il Magnifico, oramai morente, pur in età ancora giovane, dialoga, per l’ultima volta, col Savonarola, il quale, chiamato al capezzale, deve somministrargli il viatico dell’Estrema Unzione, e prima ancora il Perdono di Dio.
Riassumo: «Sí – ammette Lorenzo – so quel che ho fatto, e quel che ho fatto fare, per mantenere il potere mio e della mia famiglia; ma so anche delle opere che grazie al mio appoggio e incoraggiamento, sono state eseguite. Quel che è nato in questi anni a Firenze, da Botticelli al Brunelleschi, dal Buonarroti al Poliziano e da altri artisti, letterati e poeti, splenderà per sempre nel mondo; la mia epoca verrà ricordata nei secoli futuri come un monumento alla genialità dell’uomo. Sto morendo, lo so, ma la bellezza creata vivrà in eterno».
Il Savonarola è di tutt’altra opinione: «Tra poco la vostra anima sarà posta al cospetto di Dio. Voi credete, Lorenzo, che la tanta bellezza che dite d’aver creato, o fatto creare, gioverà a nascondere le vostre mani macchiate di sangue, le furie, le vendette del vostro egoismo, cui avete sacrificato voi stesso e i vostri cari? Pensate che Dio resterà incantato da dipinti, da musiche, da poesie, o sarà frastornato dalle vostre architetture? Di tutto questo, fra un po’ di tempo, non resterà piú nulla, e quei nomi che avete citato, di cui vi siete reso patrocinatore, non li ricorderà nessuno». In quella lista di nomi, tra l’altro, c’erano pure Marsilio Ficino, Leonardo da Vinci e Pico della Mirandola.
Non so se necessitavo di una sceneggiata televisiva, per pormi cosí a fondo la questione della bellezza in sé, quale principio estetico. Avrei potuto intuirla prima, magari attraverso letture e passi storici del Rinascimento, ma è cosí che vanno certe cose: si preparano lentamente in me senza che io ne abbia consapevolezza, e poi, tutto d’un tratto, saltano fuori, magari in concomitanza con un fatto o una situazione antinomiale, che però li suscita e in qualche modo li scatena.

Girolamo Savonarola
Quella notte non dormii; mi rigiravo nel letto pensando ora a Lorenzo ora al Savonarola; riuscivo a distinguere le ragioni di entrambi, ma avvertivo chiaramente i torti pesanti della loro umana incompletezza; che era incompletezza di pensiero. Tutti e due, da tempo, avevano imbrigliato il pensiero piegandolo al sentire e al volere dei rispettivi ego; ora, nella resa dei conti che avrebbe potuto accostare quel che avevano espresso di meglio, non s’incontravano piú.
La forza del pensare, una volta asservita alle altre facoltà, difficilmente trova riscatto nell’arco di una stessa vita.
Ciascuno, con ardimento, o con umiltà, considera se stesso un uomo fatto, completo, capace di comprendere e distinguere; ciò premesso, quel che resta dell’altro (della rappresentazione dell’altro) viene spedito al Banco della Teodicea, con la certezza (da parte del Magnifico) di essere capito o quanto meno giustificato, e la sicurezza (da parte del Savonarola) che il perdono di Dio non c’entra per niente con l’apprezzare i canoni dell’estetica terrena, e tanto meno col giustificarli.
Il dubbio che emerge dal dilemma s’impone con impellenza: fino a qual punto la bellezza dell’arte può far scudo alle malefatte umane?
È vero che i capolavori sono un patrimonio dell’umanità e che i Maestri di quelle opere vengono studiati e ricordati anche a grande distanza di tempo. Ma il frate domenicano pone l’accento sulla fenomenologia del merito che, pur stando in relazione alla grandezza del contenuto artistico, patisce la caducità e la corrosione del tempo.
Nel medesimo modo in cui si sgretoleranno le pietre delle Piramidi, nelle menti e nei cuori degli uomini si offuscherà prima o poi il ricordo dei Maestri, degli Eroi, e delle imprese che li resero tali. L’anima di frate Girolamo elaborava queste riflessioni come una fornace elabora il metallo incandescente. Fu forse il guizzare delle fiamme a impedírgli di cogliere l’oscuro presagio.
Oggi, siamo davvero convinti che fra millenni, i nostri successori sapranno ancora di Leonardo o di Botticelli? I bambini del 75° secolo continueranno a studiare gli affreschi di Michelangelo e le statue di Donatello? E ammettendo pure che lo facciano, cosa sapranno provare per le antiche testimonianze di un trapassato remoto superato in lungo e in largo da nuove scoperte psico- e tecno-logiche?
Il culto del bello vaga tra l’estetica classica, l’edonismo, fino a giungere al narcisismo nei casi dei solipsisti ostinati. La filosofia considera solo la prima delle tre forme come rilevante; le altre due possiamo ritenerle delle semplici deformazioni. E l’estetica, dal canto suo, anche per la radice del fonema, richiama l’etica, ossia la scienza della moralità. Non ho mai capito perché l’etica non sia stata chiamata “en-tetica”, in contrapposizione all’“es-tetica”, che giustamente (almeno nelle mie riflessioni) abbina e fronteggia.
In fondo la desinenza in “-tetica”, comune ad entrambe (in sostanza significa “qualcosa di prodotto, di generato”) ben spiegherebbe la finalità dell’atto artistico, dato il prefisso “es” che sta per rivolto all’esterno, mentre con il prefisso “en” verrebbe designato il valore dell’atto interno; l’unico dei due concepibile per l’appunto come morale o etico.
Abbiamo compiuto un piccolo tratto di strada e ci troviamo adesso a ragionare se l’arte abbia a che fare con la moralità. In un primo momento verrebbe da dire proprio di no; magari non sarà gradito a qualcuno, ma potremmo produrre sufficienti prove a dimostrazione che numerose sono state nel tempo le opere d’arte eseguite da mani profane se non empie. Questo tuttavia non fornisce materia di giudizio, semmai ci dice che l’arte di per sé vuole essere indipendente, sconfessionata e amorale.
Quanti la praticano con rispetto e onestà, hanno in genere afferrato come sia coltivabile solo nella dimensione della libertà totale, completa, priva di condizionamenti. Come già fu per Fabrizio De André nel profilo artistico del Suonatore Jones, pure a me «In un vortice di polvere / gli altri vedevan siccità / a me ricordava / la gonna di Jenny / in un ballo di tanti anni fa», questo non determina nulla. Siamo soltanto agli inizi; il vittimismo, anche se magistralmente raccontato, è sempre autocelebrativo; non fa fare passi in avanti.
Dicono: c’è l’Arte sacra e c’è l’Arte profana. Giusto, ma quando si vuole la sommità, le mezze quote non interessano piú. L’Arte è una: si può ripartirla in settori, branche o sottocorrenti, ma una rimane; per cui ci deve essere quella che riassume in sé tanto il saio quanto la foglia di fico. Tutto sta però a vedere di cosa essa sia l’espressione diretta. E qui ne abbiamo per tutti i gusti.
È arcinota la suddivisione dell’entità umana in Spirito, anima e corpo. Una manifestazione es-tetica può provenire da ciascuna delle tre sfere (piú gli inevitabili, ovvi frammischiamenti con le loro varianti) ma in senso lato, tendiamo a chiamare “arte” quanto intuiamo derivare dal livello del sentimento coltivato in su. Ciò non toglie che vi siano le dovute eccezioni e che la pura corporeità abbia saputo talvolta presentarsi allo sguardo del pubblico cosí come si dice si presentò Frine davanti ai giudici.
Quindi la considerazione che la bellezza fisica possa congiungersi – sempre e comunque – con l’innocenza, è una favola che viene da lontano, ma farà ancora molta strada per una umanità che non avverte il bisogno di distinguere con estrema precisione il sacro dal profano. Ogni volta che ci prova, arriva qualcuno e afferma: il peccato non sta in ciò che si vede, ma nell’occhio che guarda.
Il che in pratica equivale a giustificare qualsiasi degrado personale con formula assolutoria: «Dio mi ha fatto cosí; questa è la mia natura, e non posso farci niente».
La frase mi sta anche bene; desidererei solo che si ponesse maggior attenzione al fatto che, nella parte finale, la forma verbale “non posso” dovrebbe venir riaggiustata con un “non voglio”; cosí ci s’intenderebbe meglio.
Fin qui credo di aver dato l’impressione di considerare la bellezza nella esclusività della parvenza; se è cosí faccio ammenda, non era mia intenzione. La forma è importante, ma la sostanza lo diventa ancor piú, ove la riferiamo al suo specifico contenuto concettuale, sempre che esso sia presente e si dia al virtuale contemplatore. Altrimenti rimane inerte, come appunto si dice della materia.
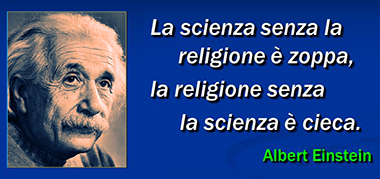 Poco meno di un mese fa, il corso di conferenze divulgative sul tema “Ipotesi sulle origini della vita dell’universo e nell’universo”, cui avevo partecipato, si chiuse tra gli applausi del pubblico mentre sullo schermo dell’aula appariva scritto a grandi lettere il celebre detto di Albert Einstein: «La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca».
Poco meno di un mese fa, il corso di conferenze divulgative sul tema “Ipotesi sulle origini della vita dell’universo e nell’universo”, cui avevo partecipato, si chiuse tra gli applausi del pubblico mentre sullo schermo dell’aula appariva scritto a grandi lettere il celebre detto di Albert Einstein: «La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca».
Commento generale dei presenti mentre sfollavano: «Bellissima frase. Un pensiero stupendo». Naturalmente non ero d’accordo, ma non dissi nulla; prima di tutto perché non sarei riuscito a controbattere la corale approvazione dell’uditorio, e poi perché, in effetti, neppure io ero in grado in quel momento di capire il motivo della mia discordanza: lí per lí pareva lieve, ma le discordanze, quand’anche di poco conto, ogni tanto nascondono profondità imprevedibili.
Cosa c’era in quel potente aforisma, pieno di sintesi conciliativa, bene augurante e ricco di dignità super partes, che non andava? Beh, innanzi tutto l’uso, secondo me fuori posto, di due aggettivi come “cieca” e “zoppa”, che per i miei gusti avvilivano il testo gravandolo inutilmente.
Richiamare due menomazioni rilevanti dell’organismo fisico umano, per meglio illustrare l’enunciato, mi sta bene se riportato dai Vangeli; le parabole del cieco nato e dello storpio sono tratte dall’immediatezza del soffrire umano; prenderli come spunto al quale accostare scienza e religione, che non sono carne e sangue bensí due ideologismi non imposti dal destino, equivale a voler usare un “effetto speciale” di basso costo, e finisce per avvilire la bellezza di quel che si vorrebbe significare.
Inoltre, pur cogliendo la positività sicuramente insita nella frase, vediamo come la medesima sia formata da due periodi entrambi inizianti con un “…senza”; senza questo… senza quello…”. La sequenza dei due avverbi ricalca un senso di perdita, di smarrimento, risalta il mancante, ciò che non c’è. Pure questo andava ad alimentare in qualche modo la mia perplessità.
Un proposito che voglia davvero risvegliare nell’anima una carica, uno slancio di generosità (anche intellettuale, perché no?) indicando una via che accomuni due discipline o correnti dell’umana applicazione, finora spaiate se non in conflitto, e condensate poi in un aforisma, non mi dovrebbe suggerire quel che non c’è, ma quel che invece sarebbe giusto ci fosse.
Si poteva ricostruire quel detto, mettendo due “con” al posto dei due “senza”. Per l’immediato consecutivo, tolta la negatività, anche gli aggettivi usati andavano ripristinati su base diversa.
«Con la religione, la scienza ci vede benissimo, e con la scienza, la religione cammina spedita».
Ma comprendo che – ovviamente – la baldanza perentoria con cui la frase era stata presentata al mondo, in una tale versione scomparirebbe e nulla saprebbe dire al grosso pubblico.
Questi erano, per grandi linee, i pensieri che mi si affacciavano quando rigiravo nella mia testa la sentenza di Einstein. Non volevo assolutamente cambiarla; sentivo però che con qualche modifica avrei potuto renderla piú accettabile, piú pulita; l’intrinseca bellezza del suo significato, manifestandosi appieno, ne avrebbe beneficiato.
Per farla breve, dopo una dozzina di tentativi, eliminai dapprima i due “senza”, sostituendoli con due “con”, anzi, ancora meglio, con le locuzioni “grazie a…”, e soprattutto togliendo gli aggettivi “cieca” e “zoppa”, che fin dall’inizio avevano un pochino limato la mia ammirazione nei confronti del motto.
A questo punto però s’imponeva un ulteriore cambiamento, giacché il risultato non riusciva ad avere la portata, la caratura e l’organicità, almeno filo-logica, dell’originale.
Pensai di lasciar perdere il tutto e dedicarmi a qualcosa di maggiormente consono alle mie capacità: non mi sentivo nei panni di un valido restauratore di detti proverbiali.
Ma poi, attraverso il susseguirsi dei pensieri voluti che aveva caratterizzato la ricerca, mi apparve una soluzione in cui colsi immediatamente l’impronta, la forza e contemporaneamente il senso di ciò che andavo cercando.
Rimaneva da compiere ancora un passo, un’ultima connessione, che ampliasse il significato delle parole “Scienza” e “Religione”: le avrei ora adoperate sostituendole con “Testa” e “Cuore”. Sarà stata una licenza poetica? Una forzatura intellettualistica? Forse. Tuttavia avvertivo con estrema chiarezza che la Scienza aveva a che fare direttamente con il pensiero (e quindi con la Testa) mentre la Religione era una disposizione dell’anima e quindi nessuno avrebbe potuto indignarsi (neppure Einstein) se nel mio elaborato la indicavo con la parola Cuore.
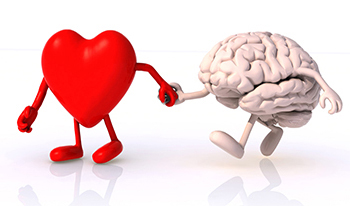 In fondo, da fonti autorevoli, apprendo che l’euristica è una disciplina degna di rispetto. Perché non usarla?
In fondo, da fonti autorevoli, apprendo che l’euristica è una disciplina degna di rispetto. Perché non usarla?
A lavoro finito, il motto si (ri)presentava cosí: «Grazie al Cuore, la Testa intuisce dove andare, e grazie alla Testa, il Cuore impara come arrivarci».
Solo successivamente mi sono reso conto che avevo preso il meglio del pensiero di Einstein e lo avevo rielaborato alla luce di quel pensiero antroposofico con il quale Rudolf Steiner ci aveva resi edotti del fatto che «la via della testa passa per il cuore» (Meditazione sulla Pietra di Fondazione).
Fu un lavoro buono, e anche oggi, a distanza di tempo, vedo che si regge bene, senza toglier nulla a nessuno; semmai aggiungendo qualcosa che all’uomo di Ulm forse era sfuggito.
In definitiva, avevo scoperto l’acqua calda; ma restare concentrati per giornate intere su un tema che ritieni importante, con il quale scopri, strada facendo, di avere un rapporto di attrazione del tutto immateriale, che però ti avvolge in modo meraviglioso la sfera dei sentimenti, costituisce uno di quei rarissimi aspetti nei quali diventa possibile sperimentare la bellezza in sé. Se dovessi provare a definire tali momenti, potrei farlo solo con le parole di un grande poeta: «…che il mondo irride, ma che rapir non può» (Alessandro Manzoni, “La Pentecoste”).
Adesso posso quindi parlare di questo tipo di “bellezza”. Potenzialmente esiste in ogni essere umano, ma mentre in natura essa sa esprimersi senza contraddirsi mai, e con la tipica spontaneità del non mediato, al nostro livello (piú elevato, piú sofisticato, se vogliamo) si propone davanti alla nostra interiorità come un’intuizione geniale e affascinante si propone al corso dei pensieri ordinari: appena comparsa, stupisce e preoccupa, alletta ed esalta, ma dopo l’immediata reazione, ci si chiede se sia stato lecito averla avuta, se non sia meglio archiviarla tra i semplici ricordi, o se, addirittura, sia meglio non pensarci piú e dimenticarla.
 Molti anni addietro, esisteva una trasmissione radiofonica, intitolata “Chiamate Roma 3131”, condotta nei primi tempi dal Dott. Paolo Cavallina. Ricordo che una sera, parlando di arte, e quindi di bellezza artistica, egli lesse una frase che mi rimase impressa a lungo, tant’è vero che la rammento bene come l’avessi sentita da poco: «L’Arte è tutto ciò che d’un tratto accende l’anima di infiniti colori, l’avvolge e la riscalda come una potente fiamma d’amore, e immediatamente l’abbandona, lasciandola nel buio di mille enigmi».
Molti anni addietro, esisteva una trasmissione radiofonica, intitolata “Chiamate Roma 3131”, condotta nei primi tempi dal Dott. Paolo Cavallina. Ricordo che una sera, parlando di arte, e quindi di bellezza artistica, egli lesse una frase che mi rimase impressa a lungo, tant’è vero che la rammento bene come l’avessi sentita da poco: «L’Arte è tutto ciò che d’un tratto accende l’anima di infiniti colori, l’avvolge e la riscalda come una potente fiamma d’amore, e immediatamente l’abbandona, lasciandola nel buio di mille enigmi».
Frase che, fosse dipeso soltanto dal Savonarola (rancoroso), o dal Magnifico (arrogante); fosse stato esclusivo appannaggio del pensiero di Dostoevskji (utopistico), o venisse celebrata dai contemporanei di Einstein (generali o ristretti) e diffusa ancor oggi per un presupposto rigor logico, che proprio del tutto logico non è, resteremmo ancora bloccati nell’oscurità dei “mille enigmi”, ove tutto può venir detto e contraddetto, e dove una sentenza vale quanto un’altra.
Dal momento che la Scienza dello Spirito non ha la pretesa di essere la soluzione di tutti gli errori, ma sostanzialmente gran parte dei nostri errori tendono a porsi il piú lontano possibile dalla Scienza dello Spirito, sarebbe cosa opportuna, anziché chiamare Roma 3131 (cui non risponderebbe oramai nessuno, ed è bene cosí), comprendere un fatto semplice, quasi elementare, che ci riguarda da vicino: l’istante in cui godiamo la bellezza dell’espressione artistica nella sua totalità è un momento pressoché magico; non si può farlo durare, né avrebbe senso cadere in questa tentazione, anche se diffusa non solo tra gli esteti piú arditi. L’anima deve trovare un suo punto di equilibrio tra pensare, sentire e volere; un circocentro capace di armonizzare le diverse nature delle tre facoltà umane; questo equilibrio richiede un rapporto diverso dal solito; a ben guardare, piú che diverso, esso è rivoluzionario, l’unico inimitabile rivoluzionario: il pensare dovrebbe trasmettere la forza impersonale della sua vis logica al sentire, che ne riuscirebbe rinvigorito come non mai, e in tal caso, il volere potrebbe cominciare ad operare per il vero bene di sé e del mondo.
Non affermo nulla di nuovo, ma non serve affermarlo là dove ogni giorno aumentano le prove di un dominio inverso: la corporeità agisce come cieco istinto del volere, accende di brame e passioni la zona del sentire, che a sua volta si appropria del pensare, obbligandolo a mirare esclusivamente al soddisfacimento dei propri bisogni.
Se in tale situazione divenuta cronica l’anima, per un breve attimo, viene messa a contatto con una verità superiore (ad esempio la bellezza artistica, ma potrebbe anche essere una delle tante altre sue espressioni) si troverebbe nella condizione del morto di sete che, in mezzo al deserto, subisce il miraggio di un’oasi.
Voglio dire: c’è sempre una distanza tra noi e ciò che crediamo sublime; distanza incolmabile perché siamo convinti che quel sublime non ci appartenga, non possa appartenerci, non ci spetti di diritto; per questo ne subiamo l’inesorabile fascinazione, che conseguentemente scompare, lasciandoci nella realtà di sempre, ma resa piú povera e squallida dal ricordo della grazia momentaneamente ricevuta.
Per questo torniamo al Louvre, torniamo a Medjugorje, torniamo là dove abbiamo incontrato il primo amore, sperando ogni volta che accada il miracolo, e che la bellezza di quel che fu ritorni festosa, scodinzolando come un cagnolino.
 Cosí sarà fintanto che continueremo a mentirci, fintanto che non accoglieremo l’idea che la bellezza, il sublime, il divino, o lo recuperiamo traendolo dal profondo del nostro intimo, o lo dovremo sbirciare attraverso le rappresentazioni e le opere altrui, con le quali il confronto sarà sempre laborioso, difficile se non impossibile.
Cosí sarà fintanto che continueremo a mentirci, fintanto che non accoglieremo l’idea che la bellezza, il sublime, il divino, o lo recuperiamo traendolo dal profondo del nostro intimo, o lo dovremo sbirciare attraverso le rappresentazioni e le opere altrui, con le quali il confronto sarà sempre laborioso, difficile se non impossibile.
L’assetato, nel miraggio, percepisce l’acqua; il suo organismo gli trasmette chiaro e forte il messaggio che è una potente richiesta della fonte di vita. Ma egli, seguendo le complesse vie del karma, si è posto nella condizione che quella fonte di vita gli debba ora apparire solo come una illusione; a tal punto realismo contingente e mèta ideale sono distanti, divergono; anche richiamandosi l’un l’altra, non possono coincidere; solo l’anelito le sopravanza. Ma gli aneliti non dissetano.
Lo studio dell’Antroposofia e gli esercizi interiori connessi alla sua disciplina, colmano questa distanza tra il reale e il vero, tra il possibile e l’impossibile, tra l’umano e il divino; creano un ponte, anzi, numerosi ponti, alcuni difficili ma tutti da percorrere. Tale cammino tuttavia non deve essere iniziato in base al desiderio esclusivo di star bene; che è un sentimento umano rispettabilissimo ma purtroppo di natura egocentrica.
La posizione corretta di chi ha deciso di inoltrarsi nelle vie dello Spirito, è quella di voler migliorare se stesso per poi… migliorare il resto. Ed è, in fondo, la partenza piú onesta: cercare di star bene significa solo sapere di star male, ma non indichiamo mai chi o cosa sia questo male.
Volersi migliorare, significa invece aver preso coscienza di non esprimere ancora in modo adeguato tutte le possibilità racchiuse nella persona in cui ci si ritrova, e allora mi sembra giusto ed anche entusiasmante provarci e vedere come va.
Non occorre andare lontano, o cercare ogni volta particolari capolavori o modelli da ammirare; il mondo su cui esistiamo e la vita che viviamo sono già i capolavori piú grandi che potessimo incontrare. La Scienza dello Spirito ci offre la possibilità di scoprirli, grazie ad una rinnovata capacità di guardare quel che di vero compare dietro al reale. Senza quello, nessun reale potrebbe sussistere.
Scrivendo, ho spesso peccato in eccesso di citazioni; per chi come me affida alla penna il suo progetto di vita, non è una bella cosa riempire le pagine con pensieri altrui. Ma in questo particolare epilogo non posso fare a meno di ripetere Massimo Scaligero. Potrebbe essere un indizio di mancata autonomia, tuttavia non mi sottrarrò alle conseguenze, anzi, ho deciso di riportare un intero passo del Maestro e di metterlo in buona evidenza sotto il titolo.
Chi cerca la bellezza di cui intendo qui parlare, sarà accontentato; potrebbe, al limite, leggere solo la determinante citazione d’apertura.
Angelo Lombroni
